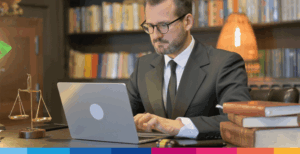Come cambia il compenso degli avvocati con la riforma 2025?

Il 4 settembre 2025 segna una data importante per l’avvocatura italiana, in quanto il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento forense, un intervento normativo che promette di ridisegnare profondamente il volto della professione legale. Tra le numerose novità introdotte, quelle relative ai compensi degli avvocati assumono un rilievo particolare, rappresentando un punto di equilibrio tra esigenze di equità, trasparenza e sostenibilità economica della professione. Questa riforma arriva a distanza di oltre un decennio dalla legge 247/2012, che aveva già segnato una svolta significativa con l’abolizione delle tariffe minime obbligatorie. Ora, con il nuovo intervento legislativo, il legislatore intende completare quel percorso di modernizzazione, introducendo strumenti concreti per tutelare sia il professionista sia il cliente, in un mercato legale sempre più competitivo e complesso.
Il principio cardine: libera pattuizione ed equo compenso
Il cuore pulsante della riforma resta ancorato a un principio già consolidato nella prassi professionale: la “libera pattuizione dei compensi” tra avvocato e cliente. Questo significa che le parti mantengono piena autonomia nel definire il corrispettivo economico dell’attività legale, attraverso accordi scritti che tengano conto della complessità della causa, delle competenze richieste e del valore economico della controversia.
Tuttavia, la libertà contrattuale non è assoluta. Il disegno di legge riafferma con forza il concetto di “equo compenso”, inteso come remunerazione proporzionata all’effettiva attività svolta, al tempo impiegato e al risultato conseguito. Non si tratta di un ritorno alle vecchie tariffe, ma dell’introduzione di un parametro di riferimento oggettivo che impedisca lo sfruttamento del professionista e tuteli al contempo il cliente da pretese economiche eccessive. L’equo compenso assume particolare rilevanza nei rapporti con i cosiddetti “clienti forti”: banche, assicurazioni, grandi imprese e pubbliche amministrazioni. La legge n. 49/2023 aveva già introdotto tutele specifiche in questo ambito, vietando clausole contrattuali vessatorie che impongano compensi manifestamente irrisori. La riforma del 2025 estende e rafforza queste garanzie, introducendo un meccanismo di solidarietà nei pagamenti che analizzeremo tra poco.
Parametri ministeriali: l’aggiornamento biennale
Una delle novità più significative riguarda la gestione dei “parametri per la determinazione dei compensi”. In assenza di un accordo scritto tra le parti, il compenso dell’avvocato sarà determinato sulla base di parametri aggiornati ogni due anni dal Ministero della Giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale Forense. Questa previsione introduce un meccanismo dinamico di adeguamento, che tiene conto dell’inflazione, delle variazioni del costo della vita e dell’evoluzione del mercato dei servizi legali. L’aggiornamento biennale rappresenta un elemento di grande innovazione rispetto al passato, quando i parametri forensi (come quelli contenuti nel D.M. 55/2014) rimanevano immutati per lunghi periodi, determinando una progressiva svalutazione reale degli onorari professionali.
Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervenendo al recente Congresso Nazionale Forense di ottobre 2025, ha confermato l’impegno del Governo nell’emanare il decreto ministeriale contenente i nuovi parametri entro la fine dell’anno, probabilmente tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Si tratta di un’attesa importante per l’intera categoria, che vede in questo aggiornamento uno strumento concreto per allineare i compensi al reale valore delle prestazioni professionali.
La rivoluzione del parere di congruità come titolo esecutivo
Tra le innovazioni più attese dagli avvocati figura senza dubbio l’attribuzione di “efficacia esecutiva al parere di congruità” rilasciato dal Consiglio dell’Ordine. Fino ad oggi, questo documento aveva una funzione meramente certificativa: attestava la correttezza della parcella rispetto ai parametri ministeriali, ma non consentiva di procedere direttamente all’esecuzione forzata per il recupero del credito. Con la riforma del 2025, il parere di congruità diventa un titolo esecutivo, equiparato a una sentenza o a un decreto ingiuntivo. In termini pratici, l’avvocato che non riceve il pagamento del proprio onorario potrà rivolgersi al Consiglio dell’Ordine per ottenere la certificazione della congruità della parcella e, una volta ottenuto il parere favorevole, avviare immediatamente le procedure esecutive (pignoramento presso terzi, pignoramento immobiliare, etc.) senza dover passare attraverso un giudizio di cognizione o un procedimento monitorio.
Questa novità rappresenta una svolta epocale nella tutela dei crediti professionali. I tempi di recupero si riducono drasticamente, passando da anni a pochi mesi. I costi del contenzioso diminuiscono sensibilmente, eliminando la necessità di ricorrere al giudice per ottenere un titolo esecutivo. Soprattutto, viene rafforzata la posizione del professionista nei confronti dei clienti inadempienti, riequilibrando un rapporto contrattuale spesso sbilanciato a favore del committente. Va precisato che l’efficacia esecutiva del parere di congruità si applica principalmente nei rapporti con i “clienti forti”, nell’ambito della normativa sull’equo compenso. Tuttavia, il disegno di legge prevede che tale meccanismo possa essere esteso progressivamente anche ad altre tipologie di rapporti professionali, configurandosi come uno strumento generale di tutela del credito forense.
Solidarietà nel pagamento: una garanzia contro l’interposizione
Un’altra innovazione di grande portata è l’introduzione del principio di “solidarietà nel pagamento del compenso”. Nei procedimenti giudiziari o arbitrari che coinvolgono più soggetti, il compenso dell’avvocato potrà essere riconosciuto non solo dal cliente diretto, ma anche da altri soggetti coinvolti nel procedimento.
Facciamo un esempio concreto. Un avvocato riceve l’incarico da una società di intermediazione che opera per conto di una grande compagnia assicurativa. Tradizionalmente, il professionista potrebbe agire solo nei confronti della società intermediaria con cui ha stipulato il contratto. Con la nuova disciplina, in caso di inadempimento, l’avvocato potrà rivolgersi direttamente anche alla compagnia assicurativa, beneficiaria effettiva della prestazione legale, per ottenere il pagamento del proprio compenso. Questo meccanismo serve a contrastare fenomeni di “interposizione fittizia” e catene di subappalti utilizzate per aggirare le tutele dell’equo compenso. Nei fatti, impedisce che grandi clienti si nascondano dietro società intermediarie per imporre condizioni economiche sfavorevoli ai professionisti.
La responsabilità solidale rende il credito più sicuro e più facilmente esigibile, garantendo una maggiore certezza nella riscossione degli onorari.
La norma si inserisce nel solco già tracciato dalla legge sull’equo compenso del 2023, che aveva introdotto tutele specifiche contro le clausole vessatorie nei contratti con imprese bancarie, assicurative e con la pubblica amministrazione. La riforma del 2025 estende e potenzia questo impianto protettivo, rendendolo più incisivo ed efficace.
Compenso “a risultato”: una novità con cautele
La riforma introduce anche la possibilità di pattuire compensi legati al raggiungimento di “obiettivi specifici”, pur mantenendo fermo il divieto del patto di quota lite. Non si tratta di una liberalizzazione selvaggia, ma di un’apertura controllata che consente maggiore flessibilità nella determinazione degli onorari. L’avvocato e il cliente potranno concordare, ad esempio, che una parte del compenso sia corrisposta solo al raggiungimento di un determinato risultato processuale o transattivo. Questa modalità, già diffusa in altri ordinamenti europei, permette di allineare gli interessi del professionista a quelli del cliente, incentivando l’impegno e la qualità della prestazione.
Tuttavia, il legislatore pone precisi paletti. Il compenso base, comunque dovuto, deve essere equo e proporzionato all’attività effettivamente svolta. La componente legata al risultato deve rappresentare un elemento accessorio e incentivante, non può sostituire integralmente la remunerazione dell’attività professionale.
Inoltre, resta assolutamente vietato pattuire che il compenso sia costituito da una percentuale del vantaggio economico conseguito dal cliente (il cosiddetto “patto di quota lite”), in quanto tale clausola violerebbe i principi di indipendenza e dignità della professione forense.
Trasparenza e forma scritta: nuovi obblighi deontologici
La riforma pone grande enfasi sulla trasparenza nella determinazione dei compensi. Viene rafforzato l’obbligo di stipulare accordi scritti che specifichino con chiarezza i criteri di calcolo dell’onorario, le modalità di pagamento, gli eventuali acconti e le condizioni per la revisione del compenso in corso di incarico. La lettera di incarico, che già oggi rappresenta uno strumento essenziale nella prassi professionale, diventa un elemento centrale del rapporto tra avvocato e cliente. Il documento dovrà indicare non solo l’oggetto della prestazione e i termini di esecuzione, ma anche una stima ragionevole del compenso complessivo, calcolata sulla base dei parametri ministeriali o di altri criteri oggettivi condivisi.
Questa previsione tutela entrambe le parti. Il cliente sa fin dall’inizio quanto costerà l’assistenza legale e può valutare consapevolmente se accettare o meno l’incarico. L’avvocato si premunisce da contestazioni successive e può documentare con precisione l’accordo raggiunto, evitando contenziosi sulla quantificazione degli onorari. In caso di mancato rispetto di questi obblighi di trasparenza, il Consiglio dell’Ordine potrà intervenire con sanzioni disciplinari, che vanno dall’avvertimento alla sospensione temporanea dall’esercizio della professione. La trasparenza, dunque, non è solo un principio etico, ma diventa un preciso obbligo deontologico la cui violazione può avere conseguenze rilevanti sulla carriera professionale.
Monocommittenza e collaborazioni continuative: tutela dell’autonomia
Un capitolo importante della riforma riguarda i rapporti di monocommittenza e le collaborazioni continuative. Molti giovani avvocati lavorano stabilmente per un singolo studio o per un’impresa, svolgendo attività legale in modo sistematico ma senza vincolo di subordinazione. Questi rapporti, per lungo tempo rimasti in una zona grigia tra lavoro autonomo e dipendente, trovano ora una disciplina specifica. Il disegno di legge qualifica tali collaborazioni come “prestazioni d’opera professionale intellettuale” ai sensi degli articoli 2229 e seguenti del Codice civile, escludendo quindi la natura subordinata del rapporto. Questa scelta tutela l’autonomia del professionista e garantisce che il compenso sia determinato sulla base dell’equità e dei parametri ministeriali, non come semplice retribuzione oraria.
Vengono individuati precisi indici di autonomia: libertà nella scelta dei tempi e dei metodi di lavoro, assenza di poteri disciplinari da parte del committente, possibilità di accettare altri incarichi, compenso determinato in funzione del risultato e non del tempo impiegato. La presenza di questi elementi impedisce la qualificazione del rapporto come lavoro subordinato e consente al collaboratore di mantenere la propria dignità professionale e la propria indipendenza.
Le prospettive future: iter parlamentare e attuazione
Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri si trova attualmente in fase di esame parlamentare presso le Commissioni Giustizia di Camera e Senato. L’obiettivo del Governo è concludere l’iter legislativo entro la fine del 2025, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nei primi mesi del 2026. Trattandosi di legge delega, il Parlamento approverà i principi e i criteri direttivi, demandando poi al Governo l’emanazione dei decreti legislativi attuativi entro sei mesi dall’entrata in vigore. Ulteriori dodici mesi saranno disponibili per eventuali disposizioni integrative o correttive, sulla base del monitoraggio dell’applicazione pratica delle nuove norme.
Parallelamente, il Ministero della Giustizia sta lavorando all’aggiornamento dei parametri forensi, che costituisce il presupposto tecnico indispensabile per rendere operative molte delle innovazioni introdotte. Come annunciato dal Ministro Nordio, il nuovo decreto dovrebbe vedere la luce tra dicembre 2025 e gennaio 2026, fornendo finalmente agli avvocati uno strumento aggiornato per il calcolo dei compensi.
Conclusioni: una riforma necessaria e attesa
La riforma dell’ordinamento forense 2025 rappresenta un passo avanti significativo nella modernizzazione della professione legale italiana. Le innovazioni sul fronte dei compensi mirano a realizzare un equilibrio tra diverse esigenze: garantire agli avvocati una remunerazione equa e dignitosa, tutelare i clienti da pretese economiche eccessive, assicurare trasparenza e certezza nei rapporti professionali.
L’introduzione del parere di congruità come titolo esecutivo, la solidarietà nei pagamenti, l’aggiornamento biennale dei parametri ministeriali sono strumenti concreti che possono fare la differenza nella quotidianità professionale di migliaia di avvocati. La strada verso una piena applicazione di queste norme sarà ancora lunga e richiederà un impegno costante da parte delle istituzioni forensi, del Ministero della Giustizia e degli stessi professionisti.
Ciò che è certo è che la riforma risponde a un’esigenza reale e profondamente sentita dalla categoria: quella di essere riconosciuti, valorizzati e adeguatamente remunerati per un lavoro che rappresenta un pilastro fondamentale dello Stato di diritto e della tutela dei diritti dei cittadini.